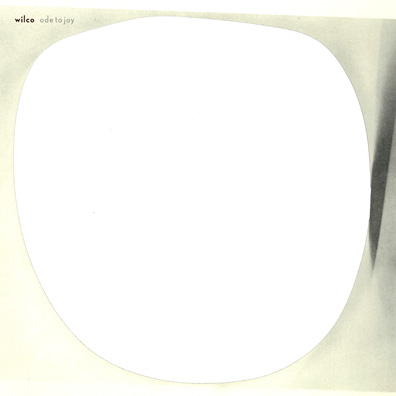
C’è sempre una guerra nelle melodie dei Wilco, una conflittualità ingombrante che sceglie sempre la via della purezza e della genuinità. Non si tratta tanto di descrivere una storia nel tempo di una canzone, ma tratteggiare i solchi interiori e le afflizioni personali che trasformano gli animi.
Questo ci insegna Jeff Tweedy, forse fra gli ultimi veri cantautori americani in grado di confrontarsi con questo tempo, un futuro che ha cambiato nazioni, uomini e sentimenti verso una divisione generale di corpi e spiriti.
Una carriera cominciata con gli Uncle Tupelo, band a cavallo tra folk e country, poi stravolta dalla creazione dei Wilco, negli anni in cui predominavano grunge, desert-rock e cross-over.
In vent’anni, il suono americano e non solo ha preso spunto dalle visioni di Tweedy e soci, per l’autorevolezza e il carisma con cui si creavano album completi e complessi, dal suono ricercato e mai approssimativo.
Dopo tanti anni, adesso, in tempi di odio, di muri e confini, in cui mantenere le distanze sembrerebbe più importante di alimentare fratellanza, l’undicesimo album in studio dei Wilco è un inno ai sentimenti umani, un colpo di spugna che cancella paure e lacrime e che non ha la pretesa di divulgare soluzioni, ma di imbastire riflessioni concrete che squarcino il silenzio.
I lieti fini sarebbero ipocrisie, meglio un insieme di prospettive, una panoramica circoscritta in undici brani che continui il percorso intrapreso dalla band americana in questi decenni.
Poche band hanno influenzato la musica d’autore contemporanea, plasmando nella stessa dimensione il cantautorato intimo e personale di Jeff Tweedy, il contributo necessario di una band all’avanguardia dell’indie-rock, la poetica ostinata che si sofferma su bandiere americane, vite comuni ed emozioni collettive.
Tutto ciò contraddistingue questa realtà musicale che ha attraversato il passaggio fra fine e inizio di un secolo, traendo ispirazione da echi beatlesiani ma anche da quell’impronta folk squisitamente americana, osservando e contemplando un’umanità dinamica e cangiante.
Ode to Joy abbandona gli scenari sonori più distorti e si proietta in una dimensione di equilibrio fra una ricerca sonora composta e la cura per le parole; perché Tweedy, oltre a essere compositore, è sopratutto un autore.
Tante le sfumature da trovare in un disco così profondo, a partire da Bright leaves che è come un risveglio, una voce sofferta che ripete I never change/you never change, come a voler mettere in chiaro una purezza personale incontaminata con un ritmo uniforme. Before us si interroga sul dolore collettivo, sulla paura dello scontro: I remember when wars would end/Remember when wars would end?/Now when something’s dead/Now when something’s dead/We try to kill it again.
Il suono acustico, con quel tocco inconfondibile, riecheggia nella mente e già delinea la struttura dell’opera. One & a half stars, ancora su questa scia sonora acustica e controllata, mette in luce altri elementi preziosi a descrivere una profonda inquietudine (I can’t escape my domain).
Non si intravede una rassegnazione, ma una ribellione morbida che mette in luce debolezze, sguardi e sentimenti, come in Quiet amplifier, in cui la melodia si costruisce gradualmente e dichiara un’incontenibile e necessaria umanità da diffondere (I Wish your world was mine).
La seconda parte dell’album apre una fase in cui la componente folk assume una dinamicità differente (Everyone hides, White wooden cross, Citizens). In We were lucky, sembra di imbattersi in una landa desolata della provincia americana, sperduta nel tempo, con la polvere e le chitarre a farne da contorno. Si sentono corde tirate e arrugginite, un ritmo quasi tribale e poi i rimpianti confusi con quei brevi assoli corrosi dalle parole It’s too late/Don’t say it/Dont’t say.
Questa progressione incalzante trova la sua piena realizzazione nel brano che, forse, è la title-track nascosta, Love is everywhere (Beware): in questo caso, il suono si sposta su un piano equilibrato ma diretto e tutto sembra chiaro così come ogni cosa appare al suo posto, soprattutto nei versi Where the sunlight grabs the lake/It’s frozen in the flames/Beneath the sleeping town/With the riots raining down/It’s all yours now.
Ogni brano sembra essere uno stato d’animo inquieto, un turbamento emotivo che scuote lo sguardo, come Hold me anyway, la parte più pop dell’album.
Infine, An empty corner, una ballata che chiude il disco e in cui l’empatia di Tweedy è completa, sofferta e condivisa.
C’è tanto da imparare da un disco del genere, forse per la maturità artistica raggiunta, ma anche per la capacità di resistere all’oscurità con una speranza concreta fatta di musica e parole.
Ode to joy sembra il disco più affine a Sky blue sky, per le atmosfere, le suggestioni e i punti di riflessione generati.
Quello che conta davvero, però, è che ormai c’è uno stile personalissimo creato dalla band di Chicago nel descrivere non solo l’America, ma tutti noi.
Dopo leggende come Neil Young o Bob Dylan che hanno raggiunto vette artistiche universali come narratori di un tempo che sembra ormai dimenticato, appartenente alla musica della seconda metà del novecento, riuscire a continuare a parlare da autori in modo arguto e dettagliato dei nostri tempi è un impegno arduo. In ogni album dei Wilco, questa prospettiva diventa concreta fra un riff corrosivo e una parentesi acustica.
Ma è sufficiente citare il frammento di un’intervista in cui Jeff Tweedy descrive nel modo più completo l’obiettivo di Ode to Joy: “the record is, in a weird way, an ode; this terrible stuff is happening, this deepening sense of creeping authoritarianism that weighs on everybody’s psyche on a daily basis, and you’re allowed to feel a lot of things at once. And one thing that is worth feeling, that is worth fighting for, is your freedom to still have joy even though things are going to shit”. Tornare alla libertà attraverso la gioia: questo sono i Wilco.
